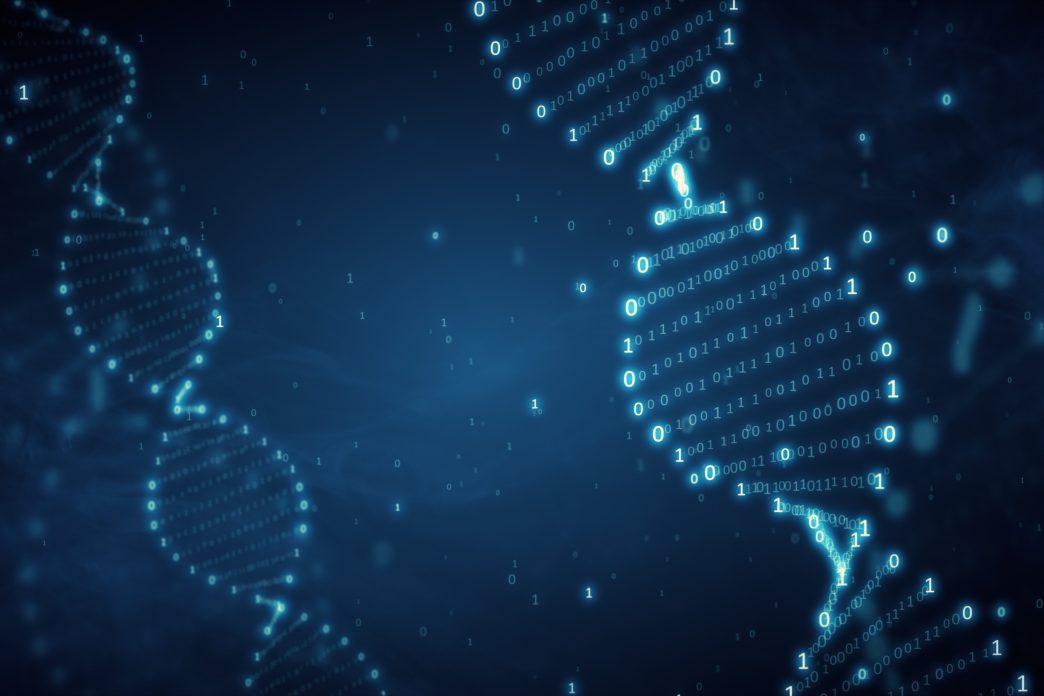La ricerca scientifica continua a progredire, spingendo sempre più in alto le frontiere della tecnologia di archiviazione dei dati. Un nuovo studio condotto da ricercatori della Columbia University ha rivelato che un grammo di DNA potrebbe custodire fino a 215 petabyte di informazioni. Questa scoperta apre scenari futuristici interessanti, dove il DNA potrebbe diventare una valida alternativa agli hard disk tradizionali. Tuttavia, le elevate spese e la lentezza nella lettura e scrittura dei dati rappresentano barriere all’adozione di questa tecnologia.
La densità informativa del DNA
Il DNA presenta una struttura molecolare unica, composta da quattro basi azotate: adenina , timina , citosina e guanina . Questi elementi fondamentali fungono da codici, simili agli 0 e 1 del linguaggio binario utilizzato dai computer. Nel 2017, Yaniv Erlich e Dina Zielinski, ricercatori presso la Columbia University, hanno dimostrato che un singolo nucleotide di DNA potrebbe rappresentare fino a 1,8 bit di informazioni. Nel loro esperimento, i due scienziati hanno ottenuto una codifica di 1,6 bit per nucleotide, avvicinandosi notevolmente a questo limite. Tale capacità di stoccaggio è davvero impressionante e offre connotati innovativi per l’archiviazione di dati.
Con l’evoluzione della tecnologia digitale e l’aumento esponenziale della produzione di dati, che secondo stime recenti potrebbe crescere enormemente entro il 2040, la necessità di nuove soluzioni per la conservazione dei dati diventa cruciale. La rivista Science ha sottolineato che il sistema sviluppato potrebbe immagazzinare ogni bit di informazione mai registrato dall’umanità in un contenitore delle dimensioni di un paio di pick-up. Questa visione futuristica, sostenuta dai numeri, evidenzia l’enorme potenziale del DNA come archivio di informazioni.
L’esperimento di codifica e decodifica
Il processo di archiviazione dei dati nel DNA non è privo di sfide. Essenzialmente, i ricercatori devono convertire i file digitali, come video e sistemi operativi, in stringhe di codice binario, comprimere le informazioni e poi tradurle in sequenze di DNA. Nel loro studio, Erlich e Zielinski hanno utilizzato un algoritmo chiamato “DNA fountain”, che ha permesso di suddividere le informazioni in brevi file di codice binario. La prima fase ha coinvolto la creazione di sei file, tra cui un film storico e un virus informatico, successivamente sintetizzati in 72.000 filamenti di DNA.
Una volta sintetizzati, i file di dati sono stati inviati alla startup Twist Bioscience per la realizzazione del DNA. Dopo l’invio, i ricercatori hanno ricevuto una fiala contenente il granello di DNA utilizzato per la codifica. Utilizzando tecnologie di sequenziamento moderne, le informazioni sono state finalmente decodificate. Il risultato? Un successo inaspettato, con i file originali ricostruiti senza alcun errore. Questo risultato ha segnato una pietra miliare nel campo della biologia sintetica e dell’informatica.
Le sfide economiche e tecniche del DNA come hard disk
Nonostante le promettenti soluzioni offerte dal DNA, ci sono ancora molti ostacoli da superare per l’applicazione pratica di questa tecnologia. Una delle principali sfide è rappresentata dai costi. Per sintetizzare 2 megabyte di dati, i ricercatori hanno dovuto affrontare una spesa di 7.000 dollari, per poi aggiungere altri 2.000 dollari per la lettura dei dati. Questa complessità economica suggerisce che l’uso del DNA come archivio possa risultare impraticabile per l’utente medio.
In aggiunta, la velocità di scrittura e lettura è significativamente più lenta rispetto ai metodi tradizionali di archiviazione. Questi fattori spingono a immaginare scenari in cui le grandi aziende, e non il singolo consumatore, possano beneficiare di questa tecnologia. L’adozione del DNA come forma di archiviazione potrebbe quindi rimanere limitata a realtà aziendali capaci di gestire e produrre enormi quantità di dati, come le grandi multinazionali nel settore tecnologico.
Il futuro del DNA come archivio di dati rimane affascinante e pieno di possibilità, ma sono necessari ulteriori sviluppi e investimenti per affrontare le sfide circostanti alla sua realizzazione operativa.